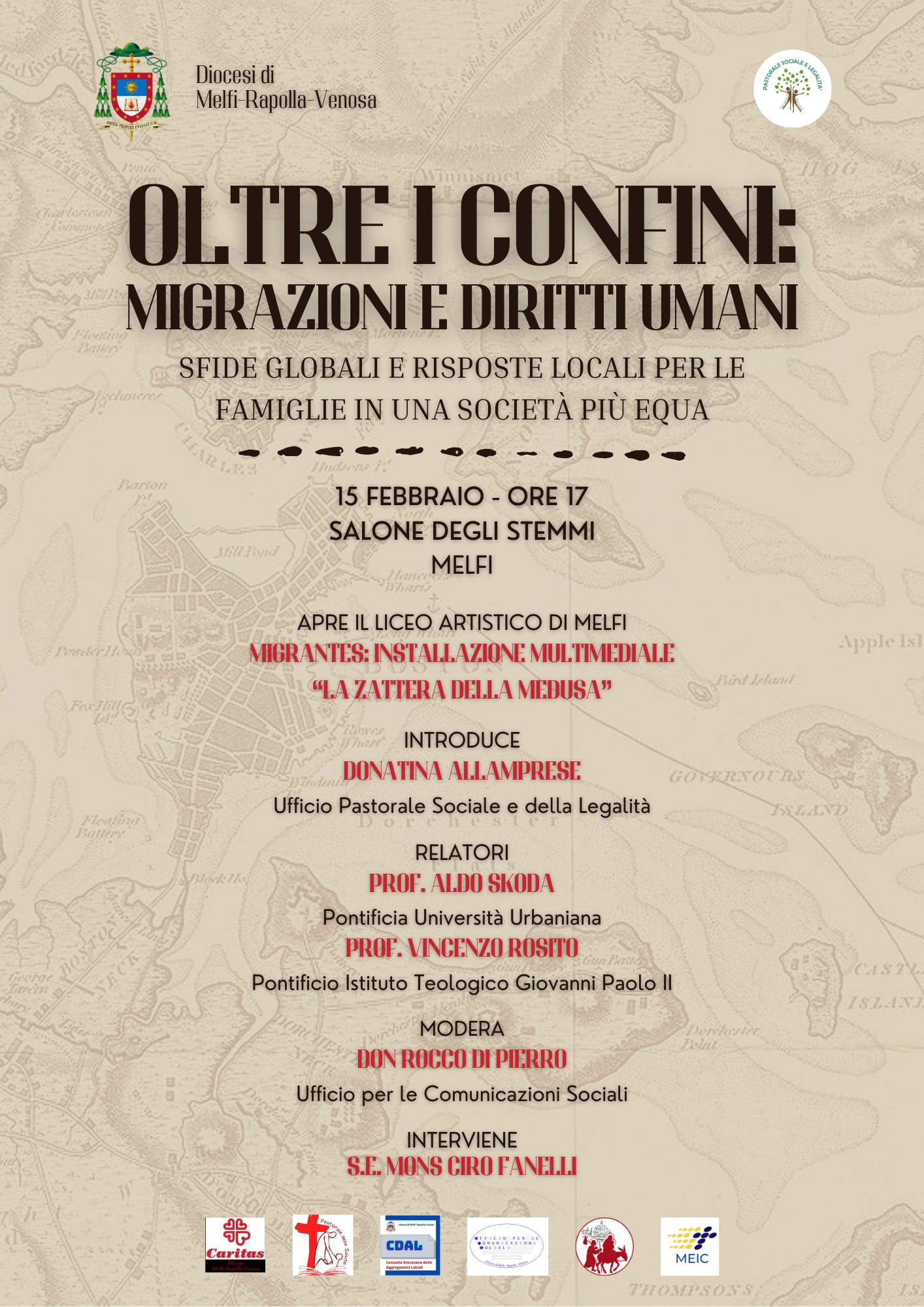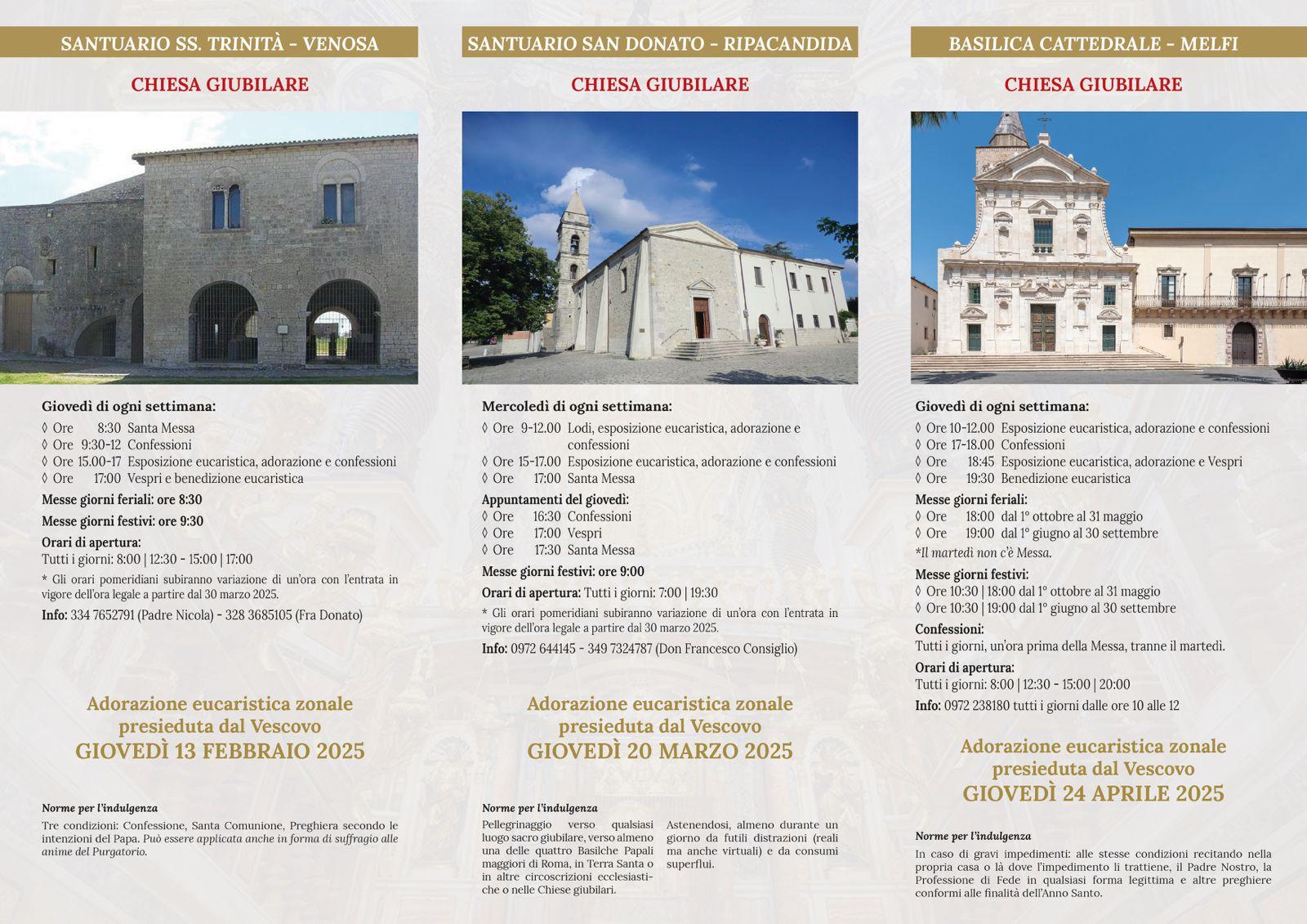Pubblichiamo, per gentile concessione, il testo dell’intervento di S.E. REV.MA MONS. FELICE ACCROCCA, Arcivescovo Metropolita di Benevento, tenutosi il 10 gennaio 2025 durante l’incontro: “Aree interne: Nuove forme pastorali capaci leggere il presente e generare un cambiamento” presso l’Aula Consiliare del Comune di Melfi.

Il coraggio di capovolgere la piramide
Melfi (PZ), 10 gennaio 2025
Sembra impossibile, eppure cose che per alcuni sono scontate, per altri rischiano (drammaticamente) di diventare inutili e oziose, quasi si tratti di questioni di lana caprina, visto che le sentono tanto lontane da loro mentre ben diversi sono i problemi avvertiti come essenziali.
Sono le aree interne a colmare il divario tra nord e sud
E questo non tra nord e sud del mondo, ma nella stessa nazione, nella stessa regione, finanche nella stessa provincia: basti pensare che in Campania, dove vivo, la provincia di Caserta confina a sud con l’hinterland napoletano – perciò con la zona a più alta intensità abitativa d’Europa – e a nord-est con il Molise, dove la densità abitativa è invece tra le più basse in assoluto. Tutta la parte interna della Campania, del resto, è caratterizzata da territori in preda allo spopolamento, minacciati da un declino che sembra inarrestabile, affetti da un costante desiderio di fuga, con paesi che continuano a perdere gli abitanti più giovani, nei quali non si trovano quasi più negozi e dove da tempo le scuole, le poste e altri servizi essenziali hanno chiuso i battenti.
La Campania, peraltro, non è la sola regione a presentare simili contraddizioni. Una gran fetta d’Italia è stretta nella morsa di analoghi problemi e non solamente quella povera (di mezzi e d’infrastrutture) del centro o del sud, ma anche quella ricca del nord, dove in molte zone cinghiali e caprioli sopravanzano in gran numero le persone: è sulle aree interne che l’Italia finalmente si eguaglia, senza più differenze. La gente si ammassa nelle periferie delle grandi città, spopolando le aree collinari e montane; l’economia e l’alta finanza favoriscono questi flussi per tanti motivi, non da ultimo perché le masse anonime sono più facilmente manipolabili e la politica – persa dietro i sondaggi, divenuti ormai pane quotidiano – sembra incapace di pensare oltre la stretta contingenza, riducendosi molto spesso a rincorrere un immediato consenso.
L’urbanizzazione – meglio, la metropolizzazione – progressiva della popolazione italiana (ma la questione assume confini planetari) sta così causando la lenta morte d’interi territori, con grave danno per tutto il Paese; come nel corpo umano la necrosi di parte del tessuto organico costituisce infatti un danno grave per l’intero organismo, lo stesso avviene quando ci si trova di fronte all’abbandono di una parte del territorio: è la nazione intera a subirne detrimento, perché un territorio non presidiato dall’uomo è inevitabilmente sottoposto a una pressione maggiore delle forze della natura, con il rischio – facile da prevedere – di nuovi e accresciuti disastri ambientali, nonché di assistere alla perdita di una parte significativa di quell’immenso patrimonio artistico-architettonico che fa dell’Italia intera un museo a cielo aperto.
Strutture idonee a stabilire connessioni umane
Nel maggio 2019 i vescovi della Metropolia beneventana dettero l’allarme (cf. doc. Mezzanotte del Mezzogiorno? Lettera agli Amministratori): rifiutando l’idea che ormai i giochi fossero fatti e l’unica possibilità rimasta fosse una sorta di accanimento terapeutico finalizzato a ritardare, quanto più possibile, la morte dei propri territori, esortarono ad agire non in maniera disorganica o, ancor peggio, scomposta, ma attraverso una progettualità profetica, con «un progetto strategico di lunga gittata che miri a privilegiare l’interesse comune, il quale solo può consentire il benessere di tutti, singole persone come enti locali». Non volevano arrogarsi compiti non propri, piuttosto proporre un metodo che, in politica come in economia, tenesse fermo il primato della comunione. Prese avvio allora un percorso che ha avuto i suoi sviluppi (si può, al riguardo, consultare il sito www.faare.org).
Essi erano – e sono tuttora – convinti che un serio progetto per le aree interne potrebbe senz’altro avere ricadute positive, anche sul piano economico, per tutta la nazione. In un contesto in cui i rapporti umani sono più forti e stabili che non negli agglomerati urbani o – peggio ancora – nelle grandi metropoli, risultano difatti più facili anche quei legami di solidarietà che in altri contesti lo Stato deve impegnarsi a garantire con grosso dispendio economico e non sempre con efficienza e – ancor meno – con efficacia. Nei piccoli Comuni, molte persone si prendono cura dei vicini anziani, vigilando su di loro a distanza, come faceva Miriam, la sorella di Mosè, quando il fratello infante, posto in un cesto dalla madre, fu affidato alla Provvidenza. Ebbene, quante persone potrebbero vivere in modo più dignitoso e sereno la propria vecchiaia in questi territori invece che in tante case di riposo, e quanto beneficio economico ne trarrebbe lo Stato se vi fosse un progetto serio per rivitalizzare queste terre?
Illuminante, in proposito, è il film di Riccardo Milani, Un mondo a parte, che attraverso la vicenda di Michele Cortese, un maestro elementare il quale, dopo aver insegnato trent’anni nella periferia romana, con bimbi disinteressati e finanche minacciosi, chiede l’assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, nell’alta Val di Sangro (si tratta in realtà di Opi, un paesino vicino Pescasseroli, nel Parco nazionale d’Abruzzo).
Nell’estate 2023 scrissi un articolo per una rivista delle scuole per l’infanzia, sostenendo che quella prima esperienza scolastica, in area interna, favorirebbe nei piccoli lo sviluppo di una struttura idonea alle connessioni umane, di un carattere più pronto ad affrontare le difficoltà agendo in autonomia, più idoneo a resistere alle sempre più pervasive pressioni dei social.
Non dobbiamo infatti dimenticare che i nostri ragazzi sono oggi abilissimi nello sviluppare rapporti in rete, ma poco attrezzati per quanto riguarda anche le più banali relazioni nella vita civile, al punto da apparire del tutto incapaci ad affrontare un impiegato dietro a uno sportello, dimostrandosi tanto impreparati a spiegare de visu, a voce e con calma, un reclamo, quanto sono invece abili a gridare la loro rabbia sui social. È quindi di una struttura idonea a stabilire connessioni umane che le persone hanno soprattutto bisogno, di un pensiero capace di elaborare criticamente le notizie per risultare meno manipolabili, per poter agire in autonomia limitando il più possibile i condizionamenti esterni. Ebbene, ritengo che, a tal fine, sia più facile porne le basi in una scuola dell’infanzia collocata in area interna.
Lo stesso potrebbe dirsi per tante attività educative finalizzate a favorire un rapporto diverso con l’ambiente, a sviluppare una mentalità non predatoria, ma dialogica, con i beni che la natura pone a disposizione dell’uomo (ancora una volta esemplare, in tal senso, è il film – già citato – di Riccardo Milani). Nei piccoli centri delle aree interne, a proposito, si potrebbe più facilmente abituare i piccoli al contatto con gli animali: far vedere loro i pulcini o addirittura i vitellini appena nati, far capire loro con quanto amore gli animali proteggono e nutrono i piccoli e che, in natura, uccidere uno dei genitori significa, automaticamente, condannare a morte anche la prole. Tutto ciò rappresenterebbe un miglioramento importante anche per la vita di tanta popolazione anziana.
Una questione decisiva: capovolgere la piramide
Le potenzialità sopraccennate, tuttavia, resteranno lettera morta se mancheranno i collegamenti tra il centro e la periferia. Perché mai un giovane dovrebbe trattenersi in un piccolo paese dell’entroterra fino a quando questo non sarà comunque facilmente collegabile con altri centri dove poter trovare quel che gli manca? Perché non assecondare il desiderio di novità che, soprattutto in età giovanile, è forte già di per sé? Credo che ogni discorso sia destinato a restare senza futuro fin quando non si rovescerà la piramide, fino a quando, cioè, nell’impiantare i servizi non si seguirà un criterio diametralmente opposto a quello che fino ad ora si è di norma seguito.
Mi spiego. Nel costruire nuove strade, nuove reti telematiche, si parte abitualmente dal centro per dirigersi poi verso le periferie, con il rischio – per nulla evitato – che alle periferie non si arrivi e invece ci si fermi a metà strada, per motivi che tutti ben conosciamo: le lentezze burocratiche rallentano spesso i lavori, i prezzi lievitano al punto che il preventivo fatto in partenza dev’essere rivisto e il finanziamento previsto non basta più a coprire le spese, facendo sì che i lavori restino incompiuti. Cosa che si è spesso già verificata e – facile profezia – si verificherà ancora, facendo sì che le zone più lontane e meno servite debbano subire penalizzazioni ulteriori.
Viceversa, capovolgendo la piramide, partendo cioè dalle periferie, sarebbe impossibile lasciare sprovvisto il centro: infatti, non si potrebbero certo lasciare Napoli, Roma o Torino sprovviste di banda larga (e di fatto non lo sono), quando ne fossero stati provvisti i piccoli paesi del Sannio e dell’Irpinia, dell’entroterra reatino, delle valli piemontesi più interne e lontane (che molte volte – troppe! – fanno in realtà fatica ad accedere alla rete in modo veloce e competitivo). Faccio un esempio, piccolo e poco noto, ma che tocca direttamente la mia terra: la strada Fortorina è nata per collegare Benevento a San Bartolomeo in Galdo ed aprire così anche un canale veloce tra Pietrelcina, patria di san Pio, e San Giovanni Rotondo, dove il santo frate è vissuto a lungo e dove riposano le sue spoglie. Se quella strada la si fosse iniziata a costruire partendo da San Bartolomeo in Galdo, cioè dalla periferia, oggi sarebbe ultimata, in quanto finché non avesse raggiunto il capoluogo di provincia sarebbe stata ritenuta di fatto inservibile. Viceversa, si decise di partire da Benevento e così, dopo decenni, il tratto ultimato si ferma attualmente a San Marco dei Cavoti, corrispondente a poco meno della metà del percorso originariamente previsto.
Basti questo per dire che finché non si rovescerà la prospettiva – ciò che starebbe a significare anche un cambio radicale di mentalità –, la distanza tra centro e periferia sarà destinata ad accrescersi sempre più, con ulteriore impoverimento delle aree giù più isolate.
Tuttavia, ciò non si verificherà senza una politica forte, capace d’imporre all’alta finanza scelte che l’alta finanza da sola non farà mai, perché contrarie ai propri interessi. Perché mai, infatti, le ditte, per installare la banda larga, dovrebbero partire da zone con pochi clienti riservando a un secondo momento la copertura di quei territori dove la popolazione invece si addensa? In una parola, perché partire dall’osso quando si può subito azzannare la polpa? Solo una politica forte, degna di questo nome, con un’alta visione di quello che è il proprio ruolo e il proprio compito, potrebbe imporre scelte, facendosi valere non solo di fronte ai potentati economici, ma alla maggioranza stessa della popolazione. Purtroppo – l’ho detto già, e non me ne vogliano i politici presenti – mi sembra che a dettar legge siano invece i sondaggi, che richiedono continuamente di aggiustare il tiro per riguadagnare il consenso eventualmente perduto.
Altre questioni da affrontare
Mi permetto inoltre di porre una questione ulteriore, che potrà essere valutata e discussa – qualora se ne riconoscesse la fondatezza – da chi ha la competenza e l’autorità per farlo: molte cose potrebbero in effetti cambiare se il criterio del numero degli abitanti non fosse l’unico in base al quale assegnare le risorse; seguendo tale criterio, infatti, le Aree interne, povere di popolazione, finiscono per ritrovarsi prive di risorse, e ciò anche se molte volte debbono provvedere a territori vasti, spesso collinari o montani, dove l’orografia rende le comunicazioni più difficili e – quindi – più dispendiose. Perché non tener conto, quando si assegnano le risorse, anche della superficie e della tipologia del territorio a cui la popolazione che ne beneficia deve provvedere?
E non sarebbe possibile istituire tassazioni differenziate per categorie che, lavorando in zone e con volumi diversi, producono anche guadagni fortemente variegati? È giusto, infatti, tassare allo stesso modo un bar situato nel centro di Roma, magari all’uscita delle grandi stazioni ferroviarie o metropolitane, che alle otto di mattina ha fatto già centinaia di caffè e venduto altrettanti cornetti, e i bar dei nostri piccoli paesini che alla sera di caffè ne avranno fatti sì e no poche decine?
È chiaro, però, che questo richiede anche un tributo da parte della nostra gente: se si vuole che i piccoli esercizi continuino a vivere in tanti piccoli paesi, perché – mantenendo viva la dimensione sociale – contribuiscono in modo determinante alla qualità della vita, è infatti necessario che tutti siano disposti ad aggiungere al prezzo da pagare anche un ulteriore tributo in grado di compensare quella qualità di vita che i piccoli esercizi mantengono alta, dal momento che un esercizio commerciale non è soltanto un locale in cui si fanno acquisti, ma un punto naturale d’incontro che offre alla gente delle ragioni di vita. Quando un negozio chiude è un pezzo di paese che muore; quando i negozi non ci saranno più, non ci sarà più neppure il paese. Con tutta evidenza, un piccolo negozio non può tuttavia essere competitivo nei prezzi con un grande centro commerciale: non si può pensare, allora, che gli abitanti dei piccoli paesi facciano spesa nei grandi centri commerciali salvo poi acquistare in loco quelle poche cose che ci si è dimenticati di prendere in città; essi dovranno quindi essere disposti a far vivere i loro negozi pagando qualcosa in più, perché da quelli non acquistano solo prodotti, ma ricevono qualità di vita.
Imparare a lavorare in rete
C’è poi un altro aspetto sul quale riflettere e lavorare insieme. Il primo ostacolo da superare – a livello sia ecclesiale che civile – resta difatti la difficoltà a costituirsi in rete, a unire le forze, giacché l’orizzonte ristretto ha spesso spinto a scelte individuali piuttosto che a fare gioco di squadra, con il risultato paradossale di vedere Comuni molto vicini tra loro costruire nuovi edifici scolastici quando né gli uni né gli altri avevano bambini sufficienti per riempirli. E lo stesso può dirsi a livello ecclesiale, con la moltiplicazione di strutture che poi finiscano per restare inutilizzate. Se cediamo alla tentazione di voler fare tutto da soli per dire a tutti che siamo più bravi degli altri, andremo incontro a un suicidio collettivo: ogni Comune non potrà avere tutto, perché quand’anche trovasse i fondi per realizzare una qualsiasi struttura, non li avrebbe poi per mantenerla in vita. Lo stesso discorso vale per le parrocchie e – ad alcuni livelli – anche per le diocesi. Dobbiamo agire uniti pensando che l’insieme non sia un solo Comune o una sola parrocchia, evitando di mettere in piedi duplicati che non potremo mantenere, servendoci gli uni delle strutture degli altri, spostandoci anche, quando è necessario, perché ormai ci si sposta per ogni cosa (ci si sposta anche nelle grandi città o nelle metropoli, con la differenza che lo spreco di tempo e lo stress che là ne derivano risultano moltiplicati).
Una pastorale per le Aree interne
Cammin facendo, si è andata inoltre manifestando in maniera crescente l’esigenza di mettere a fuoco la questione anche da un punto di vista più strettamente pastorale, poiché le aree interne si trovano a fronteggiare problemi del tutto diversi da quelli con cui sono chiamate invece a misurarsi le aree urbane o metropolitane o turistiche: molti piani pastorali disegnati a livello nazionale, in realtà, sono più tagliati per una dimensione cittadina che non per le zone dell’entroterra (ad esempio, si discute spesso dell’impiego nella pastorale catechistica dei mezzi audiovisivi quando in simili realtà mancano i bambini, dell’utilizzo di Internet quando nei piccoli paesi si fatica ad avere la rete WiFi, di pastorale familiare quando il più delle volte le giovani famiglie sono una vera e propria rarità…).
È per questo che ogni anno (nell’estate 2024 si era già al quarto appuntamento), decine di vescovi (quest’anno erano oltre trenta, provenienti da tredici diverse Regioni italiane, dal Piemonte fino alla Calabria, Sicilia e Sardegna, con la partecipazione dei vertici della CEI, vale a dire del Cardinale Presidente, Matteo Zuppi, e del Segretario Generale, Giuseppe Baturi) si ritrovano per due giorni a Benevento al fine di avviare un confronto con l’obiettivo, se non di enucleare una pastorale per le aree interne, almeno di abbozzarne qualche linea.
Certo, in queste zone – e soprattutto al sud – sembra avere ancora una forte presa la religiosità popolare con le sue tradizioni e i suoi riti che, in molte circostanze, finiscono per prescindere da un vissuto di fede: ci si deve dunque domandare come valorizzare l’esistente, purificando evidenti anomalie ed evitando, al tempo stesso, di gettare quanto vi è di buono assieme all’acqua sporca. Ugualmente complessa da affrontare è la possibilità di vedere nei flussi migratori, sempre più frequenti, un sostegno per i molti paesi oggi soggetti a un decremento progressivo della popolazione, dato che una simile evenienza pone il problema di pensare una pastorale attenta alle relazioni ecumeniche e interreligiose che, allo stato attuale, è in gran parte ancora sulla carta.
“Un mondo a parte”
Mi avvio a chiudere tornando, ancora una volta al bel film di Milani, il cui grido di battaglia è «La montagna lo fa», cambia cioè persone e cose (anche se non sempre, sia detto per onestà, le migliora). Trasferitosi nella piccola scuola di montagna di Rupe, il maestro elementare Michele si trova davanti pochi alunni – una pluriclasse con prima, terza e quinta elementare – in una scuola che rischia di chiudere i battenti e per mancanza d’iscritti e per la tragica lotta scatenatasi tra poveri pure accumunati dal medesimo destino, cancro pervasivo che spinge a dividere le forze piuttosto che ad unirle: a minacciare la scuola di Rupe sono infatti anche le mire del preside dell’istituto comprensivo e, soprattutto, del sindaco del paese vicino di poco più grande, il quale non esita a ricorrere a colpi bassi pur di raggiungere il proprio obiettivo. Si tratta allora di salvare la scuola da un possibile accorpamento, al fine di evitare che il paese faccia la fine di Sperone, un altro piccolo agglomerato di case abbandonato da tutti i suoi abitanti dopo che la scuola era stata chiusa.
Il vero male da combattere è tuttavia la rassegnazione, «che si mangia a morsi, come la scamorza», e la frammentazione, generata da piccole invidie e dal comportamento rinunciatario dei più, che spinge perfino a desiderare il fallimento di chi vorrebbe invece reagire: «E così sono tutti contenti. Tutti perdenti, tutti contenti», dice la vicepreside Agnese a Michele nel commentare la decisione di Duilio, un giovane che ha invece deciso di restare motivando la sua scelta con una semplice affermazione difficile da contrastare: «Perché io qua sto bene mae’! Perché devo andare via da casa mia?».
L’impresa nella quale si coalizzano tutti (personale scolastico, istituzioni e paesani), sarà perciò quella di salvare la scuola aggregando ai pochi alunni del posto bimbi ucraini e nordafricani (quest’ultimi ormai di seconda generazione, pienamente padroni del dialetto locale). «La montagna lo fa»! E in effetti a Rupe Michele diventa un altro: da idealista con i piedi per aria, decontestualizzato (capace di citare ai genitori di Duilio, contrariati dalla decisione del figlio, concetti sulla «restanza» tratti dal libro di Vito Teti), si trasforma in una persona sicura di sé, decisa a tutto pur di raggiungere l’obiettivo.
Il film è ben condotto, anche se con qualche caduta, e gli attori si rivelano all’altezza della situazione, non solo per la bellissima prova offerta da Antonio Albanese (il maestro Michele) e Virginia Raffaele (la vicepreside Agnese), ma anche da tutti quegli interpreti non professionisti, piccoli e grandi, che arricchiscono il quadro, a volte traendo spunto da storie reali, come quella di Duilio, il quale – proprio come nel film – ha davvero messo su un’azienda agricola che produce cereali («I primi cinque chili di lenticchie te li compro io», gli promette Agnese, che l’incoraggia nell’impresa). La stessa parlata dialettale, libera da fronzoli e pudori, va dritta al cuore dei ragionamenti e delle cose. Con Un mondo a parte, Milani mette così il dito sulla piaga, trattando questioni che dovremo affrontare anche noi, rimboccandoci le maniche tutti insieme.
Una parola per concludere
C’è bisogno d’intelligenza politica e d’intelligenza pastorale per ravvivare luoghi in cui la vita rischia di finire e dove – paradossalmente – essa può invece assumere una qualità superiore: perché i giovani che lasciano i loro paesi per i grandi centri, non vanno certo ad abitare a piazza Navona a Roma o nella zona centrale e più chic di Milano; vanno, essenzialmente, a infoltire l’anonimato delle periferie. È dunque qui, nelle Aree interne, dove la vita non vuole morire, che si gioca il futuro della nazione. Da allora, da quel maggio 2019, quando i vescovi – intervenendo sulla questione – ruppero un silenzio che era divenuto assordante, il tema è divenuto ormai quasi di moda. C’è da augurarsi che esso assuma la sua centralità anche nell’agenda del governo e la questione venga finalmente affrontata con rigore, intelligenza e, soprattutto, con una progettualità a lungo raggio.
+Felice Accrocca
Arcivescovo Metropolita di Benevento